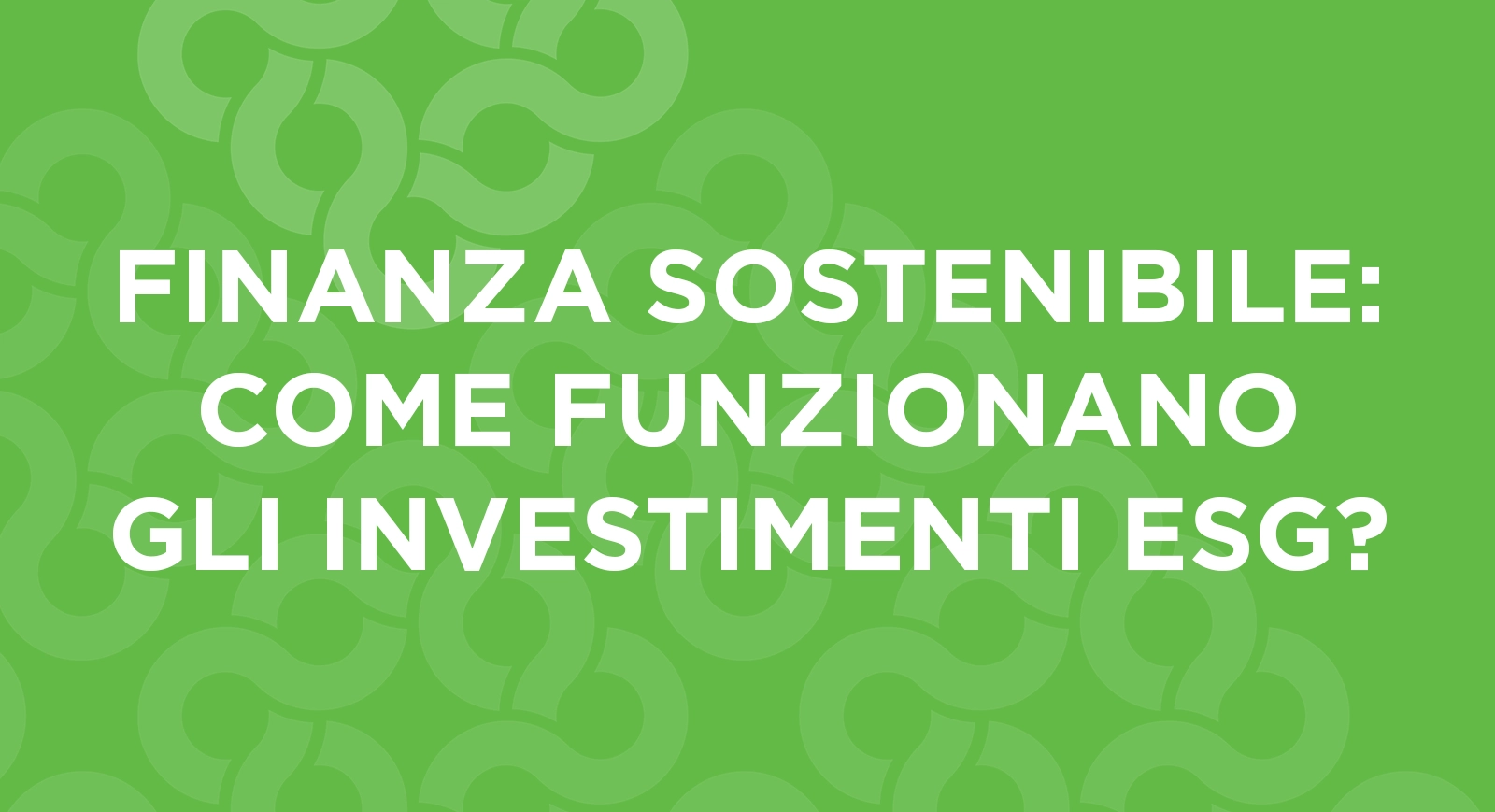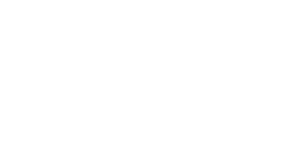Oggi sempre più investitori si interrogano non solo sul rendimento del proprio portafoglio, ma anche sul modo in cui vengono investiti e utilizzati i propri risparmi e sull’impatto che questi possono avere sul mondo. È da questa nuova e più matura consapevolezza che si sviluppa un sempre maggiore interesse verso la finanza sostenibile, una visione dell’investimento che unisce responsabilità e redditività.
La finanza sostenibile (sustainable finance) non è una tendenza passeggera, ma un cambiamento profondo nelle logiche che guidano le scelte finanziarie, capace di influenzare l’economia, la società e l’ambiente. Investire in modo responsabile significa guardare oltre i numeri, scegliendo soluzioni che creano valore non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future e il pianeta.
Vediamo più da vicino cosa significa questo approccio, cosa sono gli investimenti ESG e come distinguere le scelte davvero responsabili da quelle che lo sono solo in apparenza.
Cosa significa “finanza sostenibile”?
Per “finanza sostenibile” si intende l’insieme delle attività finanziarie che integrano criteri ambientali, sociali e di buona governance nelle decisioni di investimento. L’obiettivo è generare un rendimento economico adeguato senza compromettere le risorse naturali, i diritti delle persone o l’equilibrio dei sistemi sociali.
In altre parole, si cerca un punto di incontro tra performance finanziaria e impatto positivo sul mondo. Un investimento di questo tipo punta a creare valore nel lungo periodo, non solo per l’investitore, ma anche per l’ambiente e la collettività. Una logica che si applica tanto alle scelte individuali, quanto alle strategie di fondi, banche, assicurazioni e grandi investitori istituzionali, sempre più attenti a integrare nei propri prodotti e portafogli valori orientati alla sostenibilità.
Cosa vuol dire “ESG” e quali sono i criteri previsti?
Quando si parla di questa tematica, si menzionano spesso i fattori ESG. Cosa stanno a indicare esattamente? Il termine ESG è l’acronimo di Environmental, Social, Governance, ovvero “Ambientale, Sociale e di Governance”. Nello specifico, si tratta dei tre ambiti utilizzati per valutare la sostenibilità non solo di imprese, ma anche di strumenti finanziari e attività d’investimento. I criteri ESG permettono di comprendere quanto un’attività economica – o il titolo che la rappresenta – sia coerente con obiettivi ambientali, sociali e di buona governance. Vediamoli più nel dettaglio.
Environmental
Il primo criterio riguarda l’impatto ambientale associato a un’attività economica o a uno strumento finanziario. Uso di risorse naturali, emissioni di CO₂, gestione dei rifiuti, attenzione alla biodiversità sono tutti esempi concreti delle ripercussioni che possono esserci in tal senso. Un prodotto finanziario di questo tipo, ad esempio, potrebbe essere collegato al finanziamento di progetti per le energie rinnovabili o la transizione ecologica.
Social
Il secondo elemento esamina il rispetto dei diritti umani, le condizioni di lavoro, la tutela delle minoranze e le relazioni con stakeholder e comunità. Nella finanza sostenibile, si può dire che un prodotto rispetti questo criterio nel momento in cui i fondi raccolti sono destinati a progetti con impatti positivi che vanno in questa direzione.
Governance
Il terzo criterio riguarda la qualità e la trasparenza nella gestione dell’attività economica o dello strumento finanziario. Se nel caso di un’impresa si valutano elementi come l’etica del management, la composizione e l’indipendenza del consiglio di amministrazione, per esempio, quando si analizza uno strumento finanziario il focus si sposta sulla struttura di governance del prodotto e dell’azienda stessa che lo emette. Vengono cioè considerati aspetti come la chiarezza nell’utilizzo dei fondi raccolti, la presenza di parametri trasparenti per la selezione dei progetti da finanziare, la rendicontazione periodica e le verifiche indipendenti.
Come si distinguono gli investimenti “ESG” da quelli tradizionali?
A prima vista, un fondo “ESG” può sembrare del tutto simile a uno tradizionale. Entrambi puntano a ottenere un rendimento per l’investitore, ma ciò che li differenzia è il modo in cui viene selezionato l’ambito di investimento.
Un fondo tradizionale, infatti, potrebbe decidere di investire in qualsiasi azienda, a prescindere da cosa, come e dove essa produca, dal modo in cui tratta i dipendenti o dall’impatto che la sua attività genera sul territorio. Al contrario, un investimento “ESG” seleziona solo quelle imprese che rispettano determinati standard di sostenibilità.
Spesso, per facilitare la comprensione e il confronto tra le diverse opportunità di investimento, gli strumenti “ESG” si basano su rating di sostenibilità elaborati da società indipendenti. Questi rating assegnano un punteggio alle aziende in base alle loro performance ambientali, sociali e di governance.
Finanza sostenibile: criteri e strategie riconosciuti dalla normativa
Per garantire trasparenza ed evitare ambiguità, anche con riferimento a termini e slogan utilizzati per spiegare queste tematiche, la finanza sostenibile fa riferimento a criteri e strategie ufficiali formalmente riconosciuti dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (Regolamento UE 2019/2088) e dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852). Queste disposizioni definiscono i parametri con cui gli operatori finanziari devono considerare e descrivere gli investimenti sostenibili, consentendo agli investitori di valutare il livello di impegno ambientale, sociale e di governance di un prodotto.
Tra le principali strategie di investimento utilizzate per raggiungere tali obiettivi, ricordiamo:
- Strategie di esclusione, che evitano di investire in settori ritenuti controversi o in imprese che violano principi internazionali.
- Best-in-class, criteri che selezionano le aziende con le migliori performance ESG all’interno di ciascun settore, premiando chi dimostra maggiore impegno nella sostenibilità.
- Investimenti tematici sostenibili, che puntano su specifici temi come l’energia rinnovabile o l’inclusione sociale, ad esempio.
- Strategie di engagement, che mirano a influenzare positivamente il comportamento delle aziende attraverso il dialogo attivo da parte degli investitori.
- Impact investing, ossia gli investimenti a impatto, che finanziano progetti con l’obiettivo intenzionale di generare un impatto sociale o ambientale positivo misurabile, oltre al rendimento economico.
Un’altra componente importante per comprendere gli effetti del proprio investimento è rappresentata dai PAI – Principal Adverse Impacts (art. 4 del Regolamento UE 2019/2088), che stanno a indicare i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ESG. La normativa SFDR, quindi, richiede ai gestori di dichiarare se, e in che modo, tengano conto di queste ricadute nella selezione dei titoli e nella gestione dei portafogli.
Puntare sui fattori ESG: i vantaggi per investitori e aziende
Non solo le aziende che adottano criteri ESG traggono utilità da questa scelta. Anche per chi investe in modo responsabile esistono vantaggi reali, che vanno oltre il semplice allineamento ai propri valori.
I vantaggi per gli investitori
Chi decide di investire in modo sostenibile può andare incontro a una serie di importanti benefici. Ecco i principali:
- Migliore gestione del rischio. Le aziende ESG tendono a essere più attente alla prevenzione di rischi ambientali, legali, reputazionali e sociali. Per l’investitore, quindi, ciò si traduce in una minore probabilità che si presentino eventi critici tali da compromettere la redditività dell’investimento.
- Maggiore resilienza e stabilità. Le imprese sostenibili mostrano una maggiore capacità di adattamento e tenuta nei momenti di crisi o alta volatilità dei mercati. Questo le rende potenzialmente più stabili nel lungo periodo, a vantaggio di chi vi investe.
- Performance competitive. I fondi ESG possono offrire rendimenti pari, e in alcuni casi superiori, a quelli dei fondi tradizionali. Non è quindi solo una scelta etica, ma anche una strategia di investimento solida.
- Allineamento ai megatrend globali. Investire in imprese sostenibili significa anticipare e cavalcare i grandi cambiamenti economici e normativi legati alla transizione ecologica, posizionandosi su settori in crescita e sostenuti da politiche pubbliche.
I vantaggi per le aziende
Quali sono, invece, i benefici concreti che può trarre un’azienda che adotta criteri ESG? Scopriamo i principali:
- Maggiore efficienza operativa. L’adozione di pratiche sostenibili – come l’uso di energie rinnovabili o la digitalizzazione dei processi – consente di ridurre i costi fissi (quelli energetici, ad esempio), minimizzare gli sprechi e velocizzare le attività quotidiane.
- Migliore gestione del rischio. Le imprese ESG sviluppano sistemi integrati di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance. Ciò permette loro di identificare tempestivamente potenziali criticità e di intervenire in modo proattivo, riducendo l’esposizione a possibili sanzioni, controversie legali o danni reputazionali.
- Reputazione con clienti e stakeholder. Come appena accennato, un comportamento etico e trasparente rafforza la reputazione aziendale, aumenta la fiducia dei consumatori e facilita il dialogo con partner e investitori.
- Accesso facilitato al credito e ai capitali. Sempre più investitori e istituzioni finanziarie premiano le imprese ESG con condizioni più favorevoli, riconoscendo la loro solidità e responsabilità.
Come capire se un fondo è davvero sostenibile?
Con l’aumento dell’interesse verso queste tematiche, cresce anche il rischio del cosiddetto greenwashing, ossia di strategie di comunicazione e marketing che presentano una realtà come “responsabile” da questo punto di vista, quando invece non lo è realmente: una pratica che rischia di confondere risparmiatori e investitori. Come riconoscere un fondo davvero sostenibile? Ecco alcuni consigli:
- Leggere molto attentamente la documentazione del prodotto per capire quali criteri di selezione degli investimenti vengono adottati e quali settori sono esclusi.
- Verificare la pubblicazione periodica di report di impatto ambientale e sociale.
- Affidarsi a consulenti o gestori in grado di spiegare in modo chiaro le logiche e i risultati degli investimenti sostenibili proposti.
Obblighi di trasparenza nella finanza sostenibile
Per assicurare che gli investimenti “ESG” siano davvero sostenibili e non solo una promessa, l’Unione Europea ha introdotto regole precise che impongono a banche, assicurazioni, gestori di fondi e consulenti di comunicare con chiarezza in che modo integrano i fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni. In Italia, autorità di vigilanza come Consob e Banca d’Italia forniscono indicazioni per garantirne il rispetto.
Il percorso è iniziato nel 2018 con il Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile, che mira a orientare i capitali verso attività meno impattanti sull’ambiente, a gestire i rischi legati al cambiamento climatico e a migliorare la trasparenza nei mercati finanziari.
La normativa più rilevante in questo ambito è la già citata Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), in vigore dal marzo 2021. La SFDR chiede agli operatori finanziari di comunicare chiaramente il livello di impegno sostenibile dei loro prodotti e di rendere pubbliche le politiche ESG e i rischi ambientali o sociali presi in considerazione. Accanto alla SFDR, il Regolamento Tassonomia stabilisce quali attività economiche possono essere considerate “verdi”, fornendo una guida chiara e basata su criteri scientifici.
Se ti interessa saperne di più, puoi approfondire l’argomento leggendo il nostro documento dedicato alle scelte finanziarie sostenibili, oppure puoi scoprire come Athora gestisce il tema della sostenibilità.


 INDIETRO
INDIETRO